Durante la recita del Padre Nostro l’espressione “Rimetti a noi i nostri debiti” ha un significato ben preciso e non dobbiamo fraintenderlo.
Nel libro “La Confessione. Sacramento della Misericordia“ a cura del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione (edizioni San Paolo), la spiegazione della parabola del “Re buono e del servo spietato” (Mt 18,21-35), ci aiuta a capire anche il senso dei “debiti” citati nel Padre Nostro.
Un debito incolmabile
Nella parabola, il padrone impone al servo di pagare il proprio debito: si tratta di diecimila talenti, una somma spropositata se solo si pensa che la rendita annua del regno di Erode era di novecento talenti e il gettito delle tasse della Galilea e della Perea non superava i duecento talenti. Il racconto mira a evidenziare che in nessun caso un simile debito può essere onorato dal servo, che lo supplica disperatamente.

La compassione del padrone
La soluzione inaspettata viene (ancora una volta!) dalla «compassione» che muove l’agire del padrone. A un primo ordine di vendere «lui con la moglie, i figli e quanto possedeva» così da saldare il debito, fa invece seguito la sorprendente decisione di rimandarlo con il debito interamente condonato.
La lezione incompresa del servo
La remissione di un debito così grande dovrebbe tradursi in un qualche atteggiamento di gratitudine e di misericordia da parte di chi ne beneficia. Ma ciò non avviene: «Appena uscito» il servo si imbatte in un compagno debitore a sua volta di cento denari e da lui pretende il saldo del debito.

Cosa ci insegna la parabola
La domanda di perdono dei debiti contenuta nel Padre Nostro va compresa sullo sfondo dell’insegnamento della parabola. Dapprima una supplica: «Rimetti a noi i nostri debiti», quindi una subordinata «come noi li rimettiamo ai nostri debitori». La supplica fa riferimento all’implorazione del servo davanti al padrone, la subordinata evoca il comportamento che il servo avrebbe dovuto tenere con il compagno debitore: quello suggerito dalla compassione del re nei suoi riguardi.
Il cristiano è insolvente
Quando recita il Padre Nostro, il cristiano assume dunque il punto di vista del re della parabola, prega il «Padre celeste», che è anche «nostro», in sintonia con il suo cuore e la sua volontà. È un «servo» (syndoulos) al suo servizio entro una comunità che ha nella fraternità il suo perno costitutivo e la sua nota distintiva. Il fatto che il perdono debba essere richiesto nella preghiera implica un atteggiamento timorato (non timoroso!): poiché il debito è enorme, il cristiano sa di essere un servo insolvente.
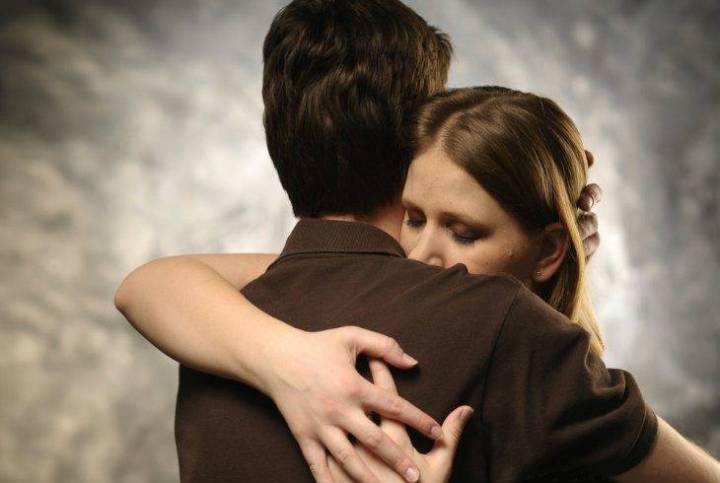
Una immensa misericordia
È davvero possibile corrispondere compiutamente a una misericordia così grande? La comunità dei credenti conosce i propri limiti e non li nasconde: essa implora sapendo di non poter contare sulle proprie forze. Essa sa che perdono e fraternità sono prima di tutto frutto di grazia e che si possono ricevere solo in dono da parte di un cuore colmo di amore come quello del Padre, Padre «celeste» e «nostro».
Cuore compassionevole
E poiché la preghiera del Padre Nostro è insegnata da Cristo, è attraverso le sue parole che la domanda del credente sale al Padre. Così come è attraverso di Lui che il cuore compassionevole del Padre si è manifestato oltre ogni misura sul legno ella croce. È ancora attraverso di Lui che il perdono è donato e muove i discepoli a riconoscersi fratelli: «Tutto questo viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione» (2Cor 5,18).






